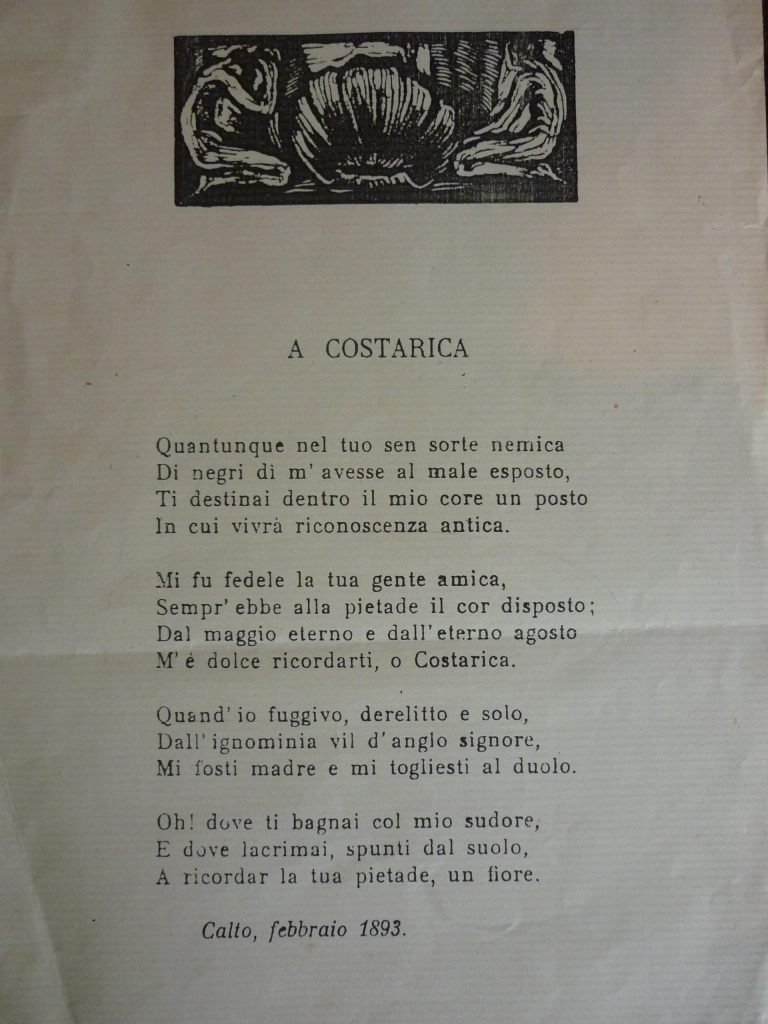Massimo Fioravanti Bosi nacque l’11 settembre 1862 a Calto, in provincia di Rovigo, da Carlo e Luigia Vallini. Figlio di contadini poveri, poté frequentare la scuola solo fino alla terza elementare, dopodiché fu costretto a lavorare nei campi per aiutare la famiglia. Nonostante ciò, fu un autodidatta appassionato: si formò da solo leggendo Dante, Giuseppe Giusti e Lorenzo Stecchetti.
Nel 1887, attratto dalla speranza di una vita migliore, partì per il Costa Rica per lavorare alla costruzione della ferrovia atlantica. Vi rimase fino al marzo del 1889, sperimentando in prima persona le dure condizioni di vita degli emigranti italiani. Denunciò in seguito le promesse non mantenute da Minor Cooper Keith, il finanziatore dell’impresa, i maltrattamenti subiti, i lavori estenuanti in ambienti malsani e l’alloggio in capanne di canne, raccontando tutto ciò come un’esperienza di abbandono e sfruttamento.
Rientrato in Italia in condizioni di povertà, si trasferì a Roma dove lavorò come muratore durante la “febbre dell’edilizia” di fine Ottocento. Anche quell’esperienza si rivelò negativa, spingendolo a tornare definitivamente nel suo paese natale, dove si dedicò all’agricoltura.
Nel 1891 sposò Lodia Marcella Crivellenti, con la quale ebbe cinque figli.
Nel febbraio del 1893 scrisse il poemetto Ricordo di Costarica, in cui rievoca, con toni emotivi e malinconici, la difficile esperienza vissuta da emigrante. Il testo rappresenta un’importante testimonianza storica sui rapporti tra gli italiani emigrati e il paese centroamericano, offrendo al lettore una rappresentazione preziosa della Costa Rica degli anni ’80 dell’Ottocento.
Nel poemetto Fioravanti mescola episodi vissuti, descrizioni della natura e riflessioni personali; si rivolge con affetto agli amici lasciati in Costa Rica, racconta la fuga dai cantieri, la costruzione della ferrovia atlantica segnata dal dolore e dalla morte. Parla poi della città di Limón ma anche di San José e della natura costaricana, descritta con espressioni di meraviglia.
Solo nel 1936, a distanza di oltre quarant’anni dalla sua stesura, il poemetto fu pubblicato all’interno della raccolta Poesie, insieme al sonetto A Costarica, anch’esso ispirato alla medesima esperienza. Entrambe le costituiscono un punto d’incontro tra la cultura italiana e quella costaricana, pressoché unico nella poesia dell’epoca.
Nel 2015 Ricordo di Costarica è stato ripubblicato in una rivista dell’Università di Costa Rica, e riconosciuto come documento di rilievo per la memoria storica del paese.